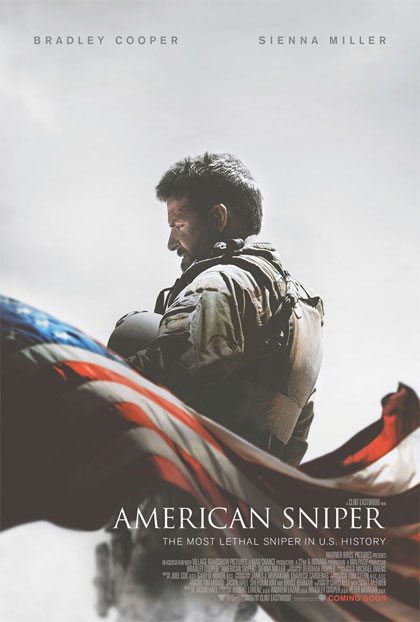Chiamasi inflazione quel crollo più o meno vertiginoso del valore di qualsivoglia oggetto perché troppo presente nel proprio circuito di riferimento e di dominio. E non solo moneta e beni commerciali possono soffrire di inflazionite acuta, ma persino idee, messaggi, conflitti (ideologici o bellici che siano), mezzi di comunicazione, culture, arti. E proprio nel calderone del detto, ridetto, trito, ritrito e rigurgitato già abbastanza mescoliamo anche noi la stessa minestra che le televisioni di tutto il mondo ci hanno servito quotidianamente ormai da tempo. Ed ecco che persino l’individuo su cui è stato depositato maggiore oblio negli ultimi decenni, vale a dire Clint Eastwood, diventa mero strumento di controversie mascherate e strumentalizzazioni politiche tutt’altro che veementi. Tanto rumore per nulla insomma. Solo creste mediatiche su un’inflazione mediatica. Perché American sniper, il film di oggi, è stato il caso cinematografico dell’anno. E diversamente da quanto possa pensare qualche autorevole critico, ciò che diventa in maniera massificata carne da macello in pasto a talk shows da lunedì sera non è di certo arte, o per lo meno non più. Un’opera d’arte tiene conto di un’unità di intenti su cui non è necessario neppure discutere dialetticamente con coloro i quali ne sono detrattori. Un’opera d’arte è, e le chiacchiere stanno a zero. Partiamo dunque da una illuminante premessa: qualunque cosa sia, di certo American sniper non è arte.
E ora che il chiacchiericcio si è assopito, interveniamo noi, scomodando uno dei maggiori critici cinematografici postmoderni, nonché filosofo: Slavoj Žižek. Egli afferma che quella che si sta combattendo nel mondo del cinema (e non solo), dagli anni Ottanta soprattutto, è una fitta guerra ideologica. Nonostante rappresentino apparentemente gli anni della distensione tra polo occidentale e polo sovietico, si è di seguito combattuto per appiattire l’intero pianeta ad un solo modello, quello non più soltanto e semplicemente borghese (datato quanto mai), ma aggiornato al nuovo stile di vita consumistico e consumato, illusivo, imprenditoriale, capitalistoide e sociopatico e individualista. Ad essere asfaltate ideologicamente sono state civiltà “altre”, davvero aliene in confronto all’idealtipo western (si pensi, ai nostri giorni, all’intero Medioriente). Ma la lobotomia non è di certo indirizzata a queste ultime, ma alle masse occidentali stesse, che hanno bisogno di registi, attori, idoli, in ultima analisi, che possano legittimare e giustificare il nostro ariano predominio culturale. E in questo contesto si inserisce il discorso su American sniper. Non c’è dubbio che sia un film schierato dalla parte dei guerrafondai occidentali, e lo si deduce già dall’approccio, analitico sì, ma relativamente al solo ambito statunitense. Il mondo arabo e islamico è passato in rassegna con una tale superficialità e indifferenza senza precedenti: un popolo crudo, inspiegabilmente spregiudicato, caratterizzato da una tendenza alla violenza più grezza e non lavorata; oppure un popolo ignavo, vendibile al miglior offerente pur di preservare la pellaccia. Ma gli perdoniamo tutto ciò a Eastwood, perché sappiamo che il suo cinema ha sempre raccontato, kantianamente e in maniera intellettualmente onesta e critica, la sola realtà che ciascun regista che si rispetti dovrebbe spiattellare sullo schermo: quella che è immediatamente sotto i suoi occhi. Allora ci si aspetterebbe che almeno venga scandagliato il fondale delle più atroci e subdole guerre del Novecento, quelle dichiarate al Medioriente, al fine di carpirne le dinamiche più o meno nascoste. Ma anche in questo caso le speranze vengono disattese. Il film si svolge “in trincea”, come si suol dire. Non vi sono alti gradi coinvolti diegeticamente, né segretari di stato, né petrolieri. Solo tanti soldati che alla guerra ci credono eccome, senza chiedersi un solo perché, senza obiettare all’ipse dixit di stato. Allora ci si sforza di cercare altrove una condanna alla guerra. E la si trova fortunatamente nell’ultima mezzora di film. Il personaggio di Kyle, interpretato da un ingenuo Cooper, in preda a stress di natura post-traumatica, sembra perdere sempre più il senno fin quando lo ritrova grazie all’appoggio della famiglia e altri reduci. Tutto risistemato, lontano dalla guerra. Ma Eastwood sembra tuonare che la guerra è uno strascico che ci si porta dietro anche lontani anni luce dal campo di battaglia. È uno stato mentale perenne che si può ripercuotere su ogni reduce anche a distanza di anni. La tragica fine del protagonista, ucciso da un ex marine, ne è la conferma. Ma proprio quando sembra terminare l’ennesimo capolavoro (o quasi) di Eastwood, il finale ci spiazza. Lo straniamento estetico-narrativo causato da quelle malsane immagini di repertorio relative al corteo funebre di Kyle danno la stessa sensazione fisiologica di una subbia conficcata inaspettatamente nella testa dello spettatore. Il quale, il più delle volte sorvolandoci su, non bada alla caduta di stile del buon Clint e torna a casa propria, un po’ come Oloferne e con la stessa sua fierezza, mutilato e con la subbia di cui sopra ancora in mostra, sbraitando di aver appena visto il film del secolo. Ora… Non si comprende bene quale fosse il tentativo del regista: se quello di denunciare la guerra ed esaltare le virtù di Kyle, il quale, tuttavia, della guerra è comunque fautore; oppure quello di proporre un modello di uomo americano integerrimo che, diversamente da Giobbe nella Bibbia, non rimprovera o rivendica nulla al proprio dio chiamato America, seppur lasciato solo; o ancora quello di denunciare ogni programma di manipolazione cerebrale e mediatica che il governo statunitense ordisce a scapito del cittadino medio, sobillandolo, inferocendolo; oppure, infine, quello di dimostrare come, nell’ora della morte di un concittadino prima abbandonato al proprio destino, gli Americani siano così fessi da celebrarlo solo perché dal passato glorioso (ed è l’opzione che spereremmo fosse valida, anche se forzata). Ciò che possiamo dire con sicurezza è che Eastwood ha probabilmente fatto ciò che più gli garbava, perché non vogliamo credere che un quasi ottantacinquenne si svenda artisticamente al consenso del proprio paese dopo una carriera impeccabile. Certo con questo film sembra deragliare verso una sorta di fondamentalismo repubblicano – o sarebbe meglio denominarlo semplicemente americano – che non lo ha mai contraddistinto veramente (nonostante possegga dagli anni Cinquanta la tessera del partito). Il suo conservatorismo moderato e progressista ha da sempre consentito che venisse considerato come il più moderno, realista e obiettivo regista di Hollywood, portatore sano di un senso morale individuale e pragmatico sotto cui sussumere un’etica universale troppo spesso non garante di eccezioni, debolezze e casistiche. Una sorta di Kant postmoderno insomma. Ma questo finale sembra adesso non lasciare adito a interpretazioni o fraintendimenti: l’America rende omaggio ad un macellaio, scannatore di centosessanta individui (armati o meno, questo non conta); ad un cecchino da videogiochi. Perché, seppur in buona fede, di questo si tratta. Certo, lo stesso Kubrick in Orizzonti di gloria ci aveva avvisato che l’unica cosa che si può fare quando ormai si è partiti per il fronte è combattere e continuare ancora a combattere. Ma ciò che più sconvolge è scorgere la guerra e il suo spirito di vanagloria anche tra le strade metropolitane e tra la gente comune che non ha mai impugnato un M24. Scoprire insomma (o, per meglio dire, avere la conferma) che la guerra non finisce al fronte, ma che non è dominio solo dei soldati reduci, in quanto stato mentale, come già detto, universale, anche della gente comune. La quale introietta volontariamente, alla morte del totem Kyle, parte della responsabilità dell’uccisione degli Iracheni da lui eroicamente abbattuti.
Ma Eastwood è sempre Eastwood. Proviamo dunque per un attimo e con enorme sforzo a perdonargli anche quest’accapponante sequenza di scorrazzate reazionarie e bandiere tremendamente nazionaliste. Chiudendo gli occhi magari. Ma se sempre restassero attivate le nostre orecchie, approderemmo al misfatto finale. Imperdonabile, questa volta, biasimabile fino all’esasperazione. Perché o il buon Clint ha dimenticato l’importanza rivestita, soprattutto in un film di guerra, dal circuito fonico oppure ha appositamente adagiato le già citate scene del corteo di Kyle su una confettura musicale esasperatamente diabetica e magniloquente. Sulle note infatti di un motivo molto simile a quello del Silenzio funebre, anche se molto più melodico e orchestrato, Eastwood sembra prostrarsi definitivamente al cospetto degli altari della patria. E se è vero che il messaggio di un film procede dal suo finale, allora il bollettino medico di American sniper recita: propagandite acuta.
C’è poi chi ha azzardato un’interpretazione storico-sociologica del film. “Sempre meglio gli Americani e il loro sfegatato patriottismo piuttosto che noi, macchiati di indifferentismo nazionale”. Aggiungendo dell’altro a questa superficialissima constatazione, potremmo tirare in ballo la storia dei rispettivi paesi e dimostrare come la differenza non sia così semplice da analizzare. Da una parte gli USA, eretti su una fanghiglia di terra e sangue nativo che non può non delegittimare ogni senso di appartenenza, anche il più genuino, in quanto geneticamente fallace. Dall’altra l’Italia e i suoi abitanti, soprattutto meridionali, i quali, pur potendo storicamente rivendicare un radicamento molto più profondo al territorio di quanto non possano fare Californiani e Texani messi assieme, preferiscono non considerarsi neppure Italiani, per via di un retaggio di antidemocraticità che ha pervaso il manovrato processo di unificazione del nostro paese. Storicamente parlando, dunque, nessun fatto di sangue ci ha mai legato realmente. Il senso di appartenenza nazionale è il più delle volte, in ultima analisi, un rito apotropaico atto a scongiurare, esorcizzare e occultare orrori del passato da cui si vuol fuggire. E la violenza commessa, come si evince anche dal film, ha un ruolo sociale, di coesione contro un nemico comune. Niente di più, niente di meno. Una violenza pianificata dall’alto e messa in atto da braccia di cittadini modello che incarnano vitelli d’oro da idolatrare. “Meglio noi che loro”, ribattiamo dunque a qualche moralista da strapazzo, destrorso o pddino che sia.
Il film ha comunque dei punti di forza. Per quanto riguarda l’organizzazione e la disposizione dei “significanti” cinematografici (ciò che in linguistica si chiama forma dell’espressione), dal punto di vista strettamente estetico-formale insomma, la pellicola, finale a parte, non mostra sbavature. Le sequenze di guerra sono volutamente di gran lunga più prolisse delle scene familiari o domestiche. Il montaggio compresso svuota al punto giusto le scene al di fuori dell’Iraq, che risultano giustamente troppo concise. Non esiste opportunità altra per il protagonista se non quella offerta dalla guerra, tra una piccola parentesi e l’altra di matrimoni, accoppiamenti, parti che hanno il sapore di “toccate e fughe”. Come se la famiglia fosse un passatempo e la patria il chiodo fisso. Singolare è la reazione in itinere dello spettatore, che ha sensazioni man mano opposte a quelle del protagonista. Seppur in balia di miriadi di pericoli mortali, Kyle si sente nel suo habitat naturale tra boati, esplosioni, tonfi, spari, urla e tempeste di sabbia. Lo spettatore invece risulta provato dopo alcune sequenze raggiungendo la pace dei sensi quando il circuito del suono tace per un attimo e Kyle torna a casa. Ma è per lui quella casa a mostrargli più fantasmi di quanti non gliene proponga l’Iraq (memorabile la scena in cui fissa la tv come se ci fosse un filmato di guerra per poi scoprire, con una panoramica, che è spenta).
Passiamo infine ad analizzare la figura probabilmente più emblematica, quella del cecchino avversario, alter ego musulmano dell’americanissimo e leggendario Kyle. Innanzi tutto possiamo dire che non è affatto logico parteggiare durante il film per Kyle imprecando per l’avversario dal momento che rivestono lo stesso identico ruolo. La sola differenza è che ancora una volta Eastwood non fa alcun riferimento anche solo fortuito alla vita del cecchino Mustafa, non introducendolo affatto nella narrazione, nella quale sbuca come una trappola nella giungla vietnamita. In questo senso il film, ancora una volta ambiguo e indecifrabile, crea una sorta di microcosmo rappresentato dalle sole gesta, assolutistiche e totalitarie, di Kyle. Il quale sembra coinvolto in un videogioco in cui le difficoltà rappresentano i vari livelli e i nemici vanno sparati e scannati senza sapere chi siano, incondizionatamente. Nessuna minima introspezione sui personaggi insomma. Come è normale che sia in guerra, si potrebbe ribattere. Esattamente, ma sta poi nella dittatura dei mezzi diegetici del regista poter andare oltre, se solo lo volesse. E, per quanto ci riguarda, questo film avrebbe potuto concernere le imprese del cecchino musulmano e non avrebbe di certo avuto una connotazione più negativa. Paradossalmente, potremmo invitare il buon Clint a realizzare un secondo film, Arabian sniper, una sorta di midquel. E ciò che diciamo ha dei riscontri nell’ennesimo scivolone del film, riguardante la post-produzione della scena dell’uccisione di Mustafa. Dunque… Il tutto parte con toni abbastanza elevati, vista la lontananza di Kyle dal bersaglio (circa due chilometri). Pur volendo dare per scontate la possibilità di colpire a quella distanza e la sicurezza di Kyle che si tratti proprio di Mastafa, l’uccisione arriva con quanto di più balordo e patetico vi sia nel mondo del cinema, se non usato con buon gusto: il rallenty. Appena sopportabile in film fumettistici, il rallenty assume qui una valenza terribilmente prosopopeica, mostrando la fuoriuscita del proiettile dalla canna a 1 km orario (che si conficca nella fronte di Mustafa a 2 km orari e mezzo) ed enfatizzando, gioco forza, dalla parte di Kyle. È vero che da qui esplode la volontà di Kyle di tornare a casa, ma quella scena rimane troppo visivamente corroborata per non essere particolarmente sentita dal regista. E il pubblico stolto quanto mai (che Eastwood dovrebbe conoscere bene) non ha fatto che applaudire dopo l’improbabile colpo da 2km, anziché esclamare un caustico “Sì va be’, come no!”. E l’inganno maggiore di Eastwood è stato quello di realizzare il film di un genere delicatissimo, di guerra, fondendolo con il genere più rischioso in assoluto, quello biografico. Ne viene fuori una sorta di biopic dalle fondamenta già abbastanza cedevoli e tutt’altro che incondizionatamente verosimile su un personaggio che non siamo nemmeno sicuri fosse così umile e parco. Strumentalizzazione, la chiamerebbe qualcuno. Mistificazione, possiamo rinominarla. Perché il personaggio è fin troppo inserito nella storia ufficiale per non riuscire, cinematograficamente parlando, a riplasmarla in modo fallace.
Chiudiamo con l’unico elemento che riteniamo davvero degno di rilievo. Quando entra in scena il cecchino musulmano, all’inizio della sequenza che porterà alla sua uccisione, viene inquadrato interamente con un carrello a retrocedere. Esso parte dai piedi dell’individuo e scorgiamo un particolare singolare: le scarpe, di colore rosso, con un marchio stampato sopra che tutto il mondo conosce bene. Si tratta del più popolare e globalizzato del pianeta, produttore di scarpe sportive. Dimenticavo, americano, americanissimo. Al di là di un semplice espediente pubblicitario col quale racimolare denari, il buon Clint vuole forse dirci altro? Vuole forse rivelarci, celatamente e in maniera subliminale (ma poi non troppo), che le miriadi di guerre in Iraq sono solo false scorribande di quartiere? O forse che tutto il mondo è già da tempo sussunto ad una realtà di mercato imposta e ad una politica culturale espansionistica? Che ad essa sia sottomessa anche quella parte di mondo che pur le si dichiara ostile, come se il mondo seguisse una direttrice progressistica che inevitabilmente ingloba tutte le civiltà? Ciò che sicuramente possiamo cogliere da questa scena è la consapevolezza che anche la guerra sia un esperimento ideologico, rivolto tuttavia a coloro i quali la subiscono mediaticamente, cioè noi. E che magari chi combatte a Bagdad, sul fronte soprattutto iracheno, non lo faccia, come si dice, per sventare il pericolo americano, ma semplicemente perché pagato, perché anch’esso mercenario (il che corrisponde a dire che gli Americani non combattono di certo per portare laggiù la democrazia). Solamente ciò ci permette, se non di riabilitare il film, comunque di applicarvi una sorta di sospensione apofantica, data l’impossibilità di poter dare un giudizio univoco sulla guerra e le vicende narrate. Ma non si rilassi troppo, maestro Eastwood. Non viene di certo assolto. La sua sentenza è solo rinviata.
Gabriele Santoro
Leggi tutto